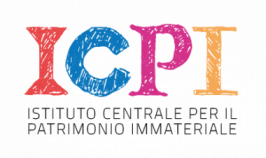La rievocazione storica
La rievocazione “Festa della Regola” mette in scena due elementi tra loro collegati in modo sinergico: la recitazione della Charta della Regola di Cavareno, una legislazione comunitaria che ha caratterizzato tutto il Trentino dal XIII al XVIII secolo, così come rinvenuta in una copia del 1632, e, dall’altra, la ricostruzione di antichi mestieri. Le Regole trentine nacquero, come messo in evidenza da Giacomoni (1991), dal fatto che gli insediamenti urbani erano caratterizzati da agglomerati architettonici: le case erano affastellate l’una sull’altra, facendo quindi sì che i pascoli e altri terreni utili a livello produttivo non fossero frazionati come nei masi alto-atesini. Di conseguenza, era necessario garantire una tutela e un’amministrazione dei terreni a pascolo e a coltivazione, così come dei boschi per la legna, ma anche altri tipi di risorse, come l’acqua. Si possono quindi distinguere due elementi diversi tra loro collegati nella Charta di Regola: a) un elemento giuridico, ovvero la Carta era uno scritto contenente norme per l’amministrazione e la tutela dei beni pubblici in comune; b) un elemento sociale, ovvero l’assemblea dei capifamiglia, convocati per deliberare gli interessi comunitari, dalla quale erano esclusi i “forestieri”, cioè coloro che non abitavano nei comuni vicini, e nella quale i “i vicini”, cioè gli abitanti delle Regole adiacenti, potevano esercitare un diritto di voto attivo.
La rievocazione storica è inserita all’interno di una settimana di eventi e manifestazioni, che vanno dall’ultima domenica di luglio fino alla prima domenica d’agosto. Nel 2022, il programma ha compreso i giorni dal 31 luglio al 7 agosto. La prima domenica di manifestazioni ha coinciso con l’inaugurazione e la presentazione della mostra tematica dell’edizione 2022, intitolata “Il Tempo Svelato: l’orologeria trentina si mette in mostra” mostra sugli orologiai trentini, in particolare nonesi, allestita presso la sala civica dell’ex chiesa di Santa Maria Maddalena. L’inaugurazione è stata preceduta dalla conferenza “Il Tempo svelato: l’arte di misurare il tempo. Storie di orologi e di orologiai”, organizzata all’interno della Sala filiale della Cassa rurale Novella e Alta Anaunia, in collaborazione con l’Associazione Hora. La mostra, visitata dalla ricercatrice in un momento successivo durante il suo sopralluogo sul campo (dal 5 al 7 agosto), è stata aperta fino al 14 agosto. La mostra, legata ai contenuti del calendario noneso, è stata curata dal Comitato della Charta della Regola, che ha preso spunto dall’attività di orologiaio dell’antenato di uno dei membri, Stefano Battocletti, il quale aveva realizzato l’orologio del campanile dell’ex chiesa di Santa Maria Maddalena. La sera del primo agosto, per l’appunto, si è avuta la presentazione del calendario noneso (Cialènder Nònes), dedicato ai campanili della valle di Non, presso la sala riunioni della sede di Cavareno della Cassa rurale Novella e Alta Anaunia. Stando al racconto di una delle curatrici della mostra presenti durante la visita della ricercatrice, la mostra sugli orologi trentini (principalmente fabbricati in Val di Non) appartiene a un collezionista milanese che è stato messo in contatto con il Comune di Cavareno dalla Soprintendenza del Trentino.
Le sere dal 2 al 4 agosto hanno previsto l’alternarsi di concerti, sia del coro parrocchiale, sia di band giovanili, e di cucina tipica nonesa, quest’ultima poi un appuntamento fisso il sabato e la domenica conclusiva della manifestazione, presso il parco dè Zinis. I momenti più significativi per quanto riguarda l’aspetto rievocativo cominciano con la sera del primo venerdì d’agosto, in questo caso il 5 agosto. Presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, si è tenuta una messa contornata da una processione in costume storico che ha rievocato la processione della Comunità di Cavareno avvenuta al termine dell’epidemia di colera del 1855, la cosiddetta “Prozesiòn [processione] del voto”. La Comunità di Cavareno aveva infatti espresso un voto per l’uscita dal periodo di colera. Quest’iniziativa era stata inserita dal Comitato della Charta fin dalle prime edizioni della Festa, dapprima al pomeriggio della domenica e, dal 2005, spostata in notturna al venerdì sera. Durante l’epidemia di Covid è stata l’unica iniziativa messa in esecuzione, caricandola anche di un significato simbolico vista l’epidemia in corso. Nell’edizione 2022, la processione non è si è potuta tenere a causa del maltempo. Il parroco ha quindi celebrato messa mentre i figuranti si sono disposti lungo il corridoio centrale della chiesa, sorreggendo i gonfaloni della Comunità di Cavareno. Al contempo, alcuni membri del Comitato della Charta hanno letto le varie letture previste per la messa dall’altare. Alla messa hanno artecipato sia abitanti di Cavareno, sia villeggianti.
La sera del sabato il palco davanti al campanile dell’ex chiesa di Santa Maria Maddalena avrebbe dovuto ospitare una sfilata dei costumi di proprietà della presidentessa del Comitato, Francesca Malench, accumulati durante la sua attività sartoriale e che hanno incluso, man mano, capi realizzati anche per la rievocazione. Il taglio dato alla sfilata in costume sarebbe stato quello del turismo in valle. La manifestazione non si è tenuta a causa del maltempo ed è stata spostata al mercoledì successivo. Nel corso della giornata, il centro storico di Cavareno si è popolato di un mercatino di prodotti enogastronomici tipici e artigianali, mentre al pomeriggio l’associazione “Museo Uomo Tempo” ha proposto una serie di laboratori sugli orologi meccanici, quindi in tema con la mostra e il calendario noneso.
Il clou della manifestazione ha coinciso con l’ultima domenica, il 7 agosto. La manifestazione si è aperta con un corteo in costume storico che, dal piazzale delle scuole elementari, ha percorso l’intera piazza principale del paese per poi confluire nella chiesa parrocchiale per la messa domenicale. Il corteo, interamente a cura del Comitato della Charta, è stato arricchito dalla presenza del gruppo storico di sbandieratori e musici “Il Cassero” di Castiglion Fiorentino, con il quale il Comitato della Charta della Regola ha collaborato per diversi anni. Il gruppo di Castel Fiorentino si compone, oltre che di sbandieratori e musici, anche di alcune dame in costume medioevale-rinascimentale, ed è associato all’omonima contrada del Palio dei Rioni di Castel Fiorentino. I musici e sbandieratori si sono disposti lungo l’ingresso dell’entrata della chiesa per accompagnare l’ingresso del corteo nella chiesa. La messa è stata celebrata da un sacerdote lodigiano che si trovava in villeggiatura con un gruppo parrocchiale, quindi esterno alla realtà di Cavareno. Durante l’omelia, ha stabilito un parallelo tra la Regola di Cavareno e il processo di adozione di un bambino: in entrambi i casi, secondo il parroco, la perdita dei legami familiari precedenti e l’esclusività degli stessi vengono sostituiti con la creazione di nuovi legami e un senso di appartenenza e di accoglienza, enfatizzando quindi gli ideali solidaristici della Regola per la comunità di Cavareno, ulteriormente enfatizzati dall’organizzazione di un evento festivo così sentito e apprezzato anche da chi è in villeggiatura. La condivisione, pilastro della Regola, sarebbe un modo per poter elaborare l’abbandono da Dio (come nel caso della Lettera agli Ebrei letta prima dell’omelia) o dai genitori (come nel caso dei bambini adottati). Il costume storico, anziché essere qualcosa di artificioso, ha la funzione di valorizzare questi legami sociali, secondo il sacerdote.
Alla fine della messa, il corteo storico si è ricomposto uscendo dalla chiesa al suono delle chiarine dei musici di Castel Fiorentino. Al tempo stesso, gli sbandieratori si sono raccolti attorno al piazzale antistante l’ex chiesa di Santa Maria Maddalena per offrire uno spettacolo con figure di gruppo.
A partire dal pomeriggio, il centro storico, in particolare la zona attorno alla piazza principale e la via che costeggia la Casa Contadina, si è popolato di membri del Comitato della Charta in costume e alle prese con la rievocazione di antichi mestieri: dal contadino per la coltivazione delle patate e sistema il fieno, alle donne per la lavorazione della lana e del feltro, fino ad arrivare al fornaio, alle lavandaie (in questo caso delle preadolescenti e adolescenti con qualche bambino e bambina al seguito) e al falegname (questi ultimi tre mestieri nei pressi della Casa Contadina). La rievocazione degli antichi mestieri si è accompagnata a una serie di giochi per i bambini, sul modello di una serie di sfide da vincere nelle varie tappe coincidenti con le varie sedi delle rievocazioni dei mestieri.
A seguito del punto ristoro al Parco de Zinis, si è tenuto un secondo corteo storico, costituito sia dai vari figuranti del Comitato, sia dalle dame del gruppo Cassero, percorrendo lo stesso percorso della mattina a lume di torce per poi allungare in corrispondenza di via Alpina, e percorrere il cortile di una casa antica. Il corteo si è concluso con l’arrivo al palco allestito sotto al campanile dell’ex chiesa di Santa Maria Maddalena. Ciascun personaggio del corteo è stato descritto da un membro del Comitato della Charta a guida dell’inizio di uno spettacolo teatrale. Trattandosi della ricostruzione di una disputa legale avvenuta con alcuni boscaioli che avevano depredato la legna della Regola di Cavareno, la speaker ha introdotto i vari personaggi coinvolti (come il saltaro, o il controllore e la guardia dei boschi pubblici, il procuratore o Sindaco, l’autorità superiore del Principe Vescovo, i Regolani, o i rappresentanti di tutta la comunità, i nobili de Zinis, di cui fa parte anche il notaio che sottoscrive la Charta) e il loro ruolo all’interno dello sceneggiato. Si è poi proceduto con la recitazione di lingua nonesa, poi tradotta regolarmente in italiano per il pubblico, della contesa, così come la lettura di alcuni passi della Regola, utilizzati per perorare la causa legale.
A conclusione della serata, sul palco sono stati presentati prima la performance di giocoleria e giochi con il fuoco da parte del duo “Moris Genny”, e, successivamente, la proiezione di un video mapping musicato utilizzando le planimetrie di alcuni edifici storici di Cavareno, in particolare il campanile.
In parallelo alla rievocazione, già a partire dalla seconda metà di luglio, si hanno le aperture della Casa Contadina, di proprietà del Comitato della Charta, con visite guidate (ogni mercoledì, sabato e domenica pomeriggio) e della chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano (ogni sabato pomeriggio, fino alla fine d’agosto), da una parte, e una serie di laboratori e letture per bambini, dal 22 luglio fino al 19 agosto. Mentre i laboratori hanno come obiettivo la costruzione di oggetti legati alla misurazione del tempo (la meridiana e la clessidra), le letture sono fiabe legate al campanile dell’ex chiesa di Santa Maria Maddalena, dove hanno anche luogo le letture stesse. Nei giorni di laboratori e letture, il paese si anima con un mercatino di beneficenza a cura del Gruppo Viola, una delle anime del Comitato della Charta della Regola.
Durante il sabato e la domenica del sopralluogo della ricercatrice (6 e 7 agosto 2022), la Casa Contadina è stata aperta nel pomeriggio ai visitatori, i quali sono stati guidati dalla figlia di Stefano Battocletti, Flora, e, talvolta, dalla moglie di Battocletti, la quale è un membro fondatore del Gruppo Viola. La visita, alla quale spesso partecipano comitive di turisti provenienti dal Veneto, è stata caratterizzata da dialoghi tra la guida e il pubblico, il quale ha riportato ricordi della sua infanzia o di quella dei nonni, entrando quindi in risonanza con gli oggetti esposti. La casa contadina si erge sopra a un fienile e ha, a fianco, una stalla. L’intera parte abitata si sviluppa su un unico piano, dove si trovano due camere da letto e una cucina con un box per neonati. Molta cura è stata posta nell’allestimento della cucina, con piccole nicchie con madonnine, e della camera matrimoniale, dove è tutt’ora visibile un documento di cessione della gestione della Latteria Sociale di Cavareno, una delle attività produttive di condivisione proprie delle Regole. La Latteria Sociale tutt’ora esiste e, nella giornata della domenica, ha dato una dimostrazione all’aperto del caglio del latte e la sua cottura, vendendo i prodotti nel negozio accanto all’azienda di produzione. Stando a conversazioni informali con i membri del Comitato della Charta, la Latteria Sociale ha chiuso l’attività produttiva, fondendosi con la latteria sociale di Romeno, ma mantenendo aperto il punto vendita. Gli abitanti ricaverebbero, infatti, maggior profitto venendo quote di latte a grandi aziende latto-casearie come la Mila.
Altro elemento da tenere in considerazione è la presenza di un’osteria (principalmente, un bar per la mescita delle birre) condotta interamente da alcuni giovani membri del Comitato della Charta. Stefano Battocletti ha sostenuto che è un modo attraverso cui tenere agganciati i giovani alla rievocazione e incentivarli a partecipare. Il locale (ricavato da un ex fienile, dentro al quale è rimasto un allestimento che lo richiama) è prevalentemente frequentato dai giovani del paese nei tardi pomeriggi e nelle serate della manifestazione.
La vestizione del corteo è avvenuta all’interno della sede del Comitato della Charta, sul retro del campanile dell’ex chiesa di Santa Maria Maddalena insieme ad altre associazioni, come il Gruppo Viola. Nella sede, oltre a conservare tutti i costumi utilizzati per la manifestazione (se non una parte, situata a casa del presidente del Comitato e del Gruppo Viola, Francesca Malench), si ha una sorta di archivio dell’associazione, in particolare tutti i numeri del calendario noneso.
Area Geografica
“Cavareno, in nones detto “Ciavaren”, è un comune di circa 1.048 abitanti e si trova intorno a 1000 m di altitudine, sul terrazzo dell'Alta Anaunia (o alta Val di Non) in provincia di Trento. I suoi abitanti sono chiamati “cavarenesi” e localmente detti i “sorsi”.” (https://www.comune.cavareno.tn.it/Vivi-Cavareno/Il-Comune-di-Cavareno ) Il paese è suddiviso negli storici sobborghi di Sovic, Splazuela, Bus e Ruch; nel secondo dopoguerra, si sono sviluppati i nuovi centri di Ausiel e Larseti. La rievocazione è in particolare legata agli edifici storici della piazza principale di Cavareno, piazza Giovanni Prati e dalla casa contadina “Ciasa dala Regola”, in via Moscabio. In questa sezione della scheda, in particolare, si mettono in evidenza la parrocchia di Santa Maria Maddalena, il campanile, che coincide con la vecchia chiesa di Santa Maria Maddalena.
L’antica chiesa di Santa Maria Maddalena, del XVI secolo, costituì fin da subito il cuore della vita comunitaria, in quanto era lì che si svolgevano le assemblee della Regola di Cavareno (cfr. Giacomoni 1991: 623; Comitato Charta della Regola di Cavareno 2021: 44). La chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena è, invece, di epoca più tarda, di stile neoromanico (costruita dal 1869 al 1873). Nel presbiterio, si conserva la tela del nobile De Zinis, dove si rappresenta uno spaccato di vita comunitaria legata alla storia della Regola, ad opera di Giovanni Battista Lampi, ritrattista delle corti europee tra Settecento e Ottocento. Lo stesso Lampi realizzò una pala del 1776 con la patrona Santa Maria Maddalena e la Vergine con il bambino, mentre il padre realizzò una via crucis collocata nella navata della chiesa (don Carlo Crepaz, 12 luglio 2019, https://www.parrocchiealtavaldinon.it/category/parrocchie-up/unita-pastorale-s-maria/cavareno/).
In epoca romanica, ovvero nella seconda metà del 1200, la chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano era dedicata ai santi Maurizio e Lorenzo, i quali affiancano la Madonna con Bambino in un affresco conservato nella parete sud della chiesa. La chiesa venne poi ampliata nel 1480 per dedicarla ai Santi Fabiano e Sebastiano, protettori dalla peste. La chiesa presenta un altare a portelle (Flügelaltar), prodotto nel 1520 da una bottega altoatesina e che proveniva originalmente dalla vecchia chiesa di Santa Maddalena. L’arredo di quest’ultima, infatti, andò distrutto con un incendio del XVII secolo, e si salvò unicamente l’altare. Le statue inserite al suo interno (Sant’Agostino, Santa Maddalena e la Madonna) sono state probabilmente adattate per farle entrare all’interno delle nicchie. Il Flügelaltar viene menzionato dallo stesso Alessandro Tevini in un commentario che redasse per l’edizione della Charta della Regola del 1632 nel 1934 (cfr. https://www.visitvaldinon.it/en/poi/chiesetta-ss-fabiano-e-sebastiano e https://www.parrocchiealtavaldinon.it/category/parrocchie-up/unita-pastorale-s-maria/cavareno/). Secondo Alessandro Tevini (1934): “Le più antiche case di Cavareno sono appunto da ricercarsi attorno alla menzionata chiesa: ancora oggi si dice “zò alle vecle” (giù alle vecchie case). […] Tutte queste case, essendo le più antiche, sono o erano pericolanti, perciò si diceva anche “zò alle murozze””” (Comitato Charta 2021: 89). La “Ciasa dala Regola” è, infatti, costruita nei pressi della chiesa.
La presenza della nobile famiglia de Zinis è visibile anche nel Castel de Campi, sito nei pressi della chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano. Il palazzo a tre piani presenta sul lato principale, a est, il portale sovrastato dallo stemma scolpito in pietra dei de Zinis, mentre il centro della facciata presenta un affresco con lo stemma della famiglia nobiliare dei Campi (https://www.comune.cavareno.tn.it/Vivi-Cavareno/Il-Comune-di-Cavareno ).
Descrizione del percorso
Il percorso del corteo parte dal retro della chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, per poi compiere tutto il giro della piazza, passando, nell’ordine, da: via alla Pineta, via Alpina, piazza Prati, per poi immettersi in via Roma. Il percorso va anche a toccare un breve tratto di strada di via Alpina caratterizzato dal cortile di una casa antica. Altre zone interessate, più in generale, dalla rievocazione sono la “Ciasa dala Regola”, in via Moscabio, e il parco situato tra via de Zinis e via Roma, all’interno del quale è situato il punto ristoro con cucina tipica nonesa. Di fronte alla “Ciasa dala Regola”, il Comitato utilizza anche la fontana, costruita secondo strutture che si possono ritrovare in altre parti del Trentino, allo scopo di fare una serie di attività con bambini e adolescenti in costume per rievocare come si lavavano i panni un tempo.
Notizie storico-critiche
Negli anni Novanta, con il sindaco Zini, vi era l’esigenza di recuperare la memoria relativa agli antichi mestieri contadini praticati a Cavareno e, più in generale, in valle. Dal momento che Zini era già interessato, da turista, al mondo delle rievocazioni storiche, in particolare alla Quintana di Ascoli Piceno, decise di riprodurre il format delle rievocazioni storiche all’interno della realtà di Cavareno e modularlo per le esigenze locali. Zini, quindi, incontrò il Gruppo delle Feste Vigiliane di Trento, ovvero deputato agli aspetti rievocativi della festa patronale di Trento (legata a San Vigilio). Il Gruppo, infatti, rappresentava un punto di riferimento per l’organizzazione di una manifestazione storico-culturale, per quanto non costituito da esperti nel campo degli antichi mestieri. La parte costumistica era seguita da Francesca Malench, ora leader del Comitato della Charta; inizialmente, i costumi venivano noleggiati. Alla rievocazione e al Comitato della Charta della Regola ha partecipato fin dall’inizio il Gruppo Viola (1992), un’associazione nata negli anni Ottanta rappresentata da giovani madri che volevano impegnarsi nel mondo della beneficenza. Il Gruppo aveva già realizzato il Carnevale al posto del Comune per sensibilizzare sulla Guerra in Bosnia. Francesca Malench ricopre il ruolo di presidente sia del Comitato che del Gruppo Viola. Il Comitato della Charta della Regola ha progressivamente acquisito importanza nel mondo delle rievocazioni storiche trentine, arrivando a ricoprire la funzione di coordinatore del FECRIT e del CORIST.
Il focus della manifestazione sugli antichi mestieri aveva incentivato una ricerca etnografica sugli stessi condotta dal gruppo locale “La Stua” (in dialetto locale, #stua# indica la stanza foderata di legno e riscaldata dalla stufa a olle, elemento imprescindibile delle case nonese e, più estesamente, trentine), operante tra gli anni Ottanta e Novanta. Quest’ultima aveva raccolto materiale fotografico per comprendere sia l’assetto originale delle case prima del boom edilizio, sia la tipologia di mestieri documentata in valle. Queste fotografie vennero utilizzate all’interno di interviste alle generazioni più anziane del paese, poi trascritte, che sono andate a costituire l’archivio, online e cartaceo, del Comitato della Charta. Il gruppo ha inoltre svolto una ricerca sui soprannomi delle famiglie locali che andavano ulteriormente a specificare e differenziare i cognomi più diffusi a Cavareno. La “Stua” ha realizzato due mostre fotografiche (1988, 1990) e un laboratorio di pizzo con un gruppo di anziane e alcune donne interessate a riscoprire le tecniche di realizzazione (1992). Con la costituzione del Comitato della Charta della Regola di Cavareno, nel 1997, “La Stua” venne poi assorbita all’interno del Comitato. “La Stua” inizialmente coadiuvava la rievocazione storica per quanto riguardava la realizzazione degli antichi mestieri. La convivenza tra la rievocazione storica e gli antichi mestieri ha avuto una natura di compromesso tra la ricerca della memoria storico-antropologica della valle e un elemento attrattivo-spettacolare, quello del corteo storico. La nobiltà, tutta presente in corteo, non rappresentava che una minima parte della popolazione nonesa nell’arco di esistenza delle Regole. Inoltre, si sono conservati pochi documenti storici rispetto alle famiglie nobiliari. La rievocazione storica ha assunto la funzione, per i membri del Comitato della Charta, di strumento per far sì che passasse un messaggio più ampio, legato al recupero, per esempio, della lingua nonesa. La ricostruzione degli antichi mestieri sarebbe, infatti, consona all’Ottocento che al secolo rappresentato dal corteo storico (tra Cinquecento e Seicento), ma è in linea con la pregnanza storico-antropologica delle Regole, che, infatti, sono esistite senza soluzione di continuità per cinque secoli, se non anche subito dopo la loro abolizione nell’Ottocento.
All’intersezione tra ricerca etnografica e rievocazione storica si è accompagnato uno studio sulla Charta della Regola. Una copia di quest’ultima venne rinvenuta da Zini nella Biblioteca Comunale di Trento, per poi restaurarla tra il 1992 e il 1994 ed esporla in una mostra ad hoc. Nonostante i documenti comunali citassero un’edizione della Charta del 1500, si rinvennero due copie più tarde: una, quella contenuta nella Biblioteca Comunale di Trento, del 1632 e un’altra, del 1755, manoscritta e a cura di Cipriano Bevilacqua, in possesso al Comune di Cavareno. La copia del 1632 venne trascritta a mano dal curato don Francesco Negri nel 1894 e, successivamente, da Alessandro Tevini del 1934, poi dattiloscritta da Olivio Battocletti. La ricerca attuata a Cavareno era parallela all’attenzione per le Regole da parte del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina a San Michele all’Adige, che realizzò, tra il 2017 e il 2018, una sala permanente dedicata alle Carte di Regola. Le Regole interessano particolarmente alla Provincia di Trento in quanto evidenziano storicamente l’autonomia delle comunità trentine. Le Carte di Regola, infatti, esistenti dal XIII secolo fino al XVIII secolo, definiscono l’organizzazione della comunità in ogni aspetto e, pur essendo abolite nel XIX secolo in quanto considerate incompatibili con l’organizzazione statale), rimangono in vigore fino alla metà del XIX secolo. In Val di Non, gli statuti di valle avevano uno scarso spessore normativo, a differenza di altri contesti, come quello della Valle di Fassa, mentre ogni singolo villaggio aveva regole interne proprie. Dal XVI al XVIII, le Carte di Regola vengono ampliate e arricchite da ulteriori riforme e aggiunte in volgare (quello che è noto come periodo “mandruzziano). Nel Settecento, alcune Carte di Regola vengono rifatte per ridurre la centralità delle assemblee comunitarie e, quindi, il livello di conflittualità attraverso dei rappresentanti eletti (si veda Giacomoni 1991).
La particolarità della trascrizione e delle annotazioni di Tevini sulla Charta del 1934 è che riporta nomi di luoghi, personaggi, eventi citati dai racconti del padre e del nonno, dalla testimonianza di contemporanei, così come dalla stessa memoria d’infanzia dell’autore, restituendo, quindi, uno spaccato antropologico sul paese e la permanenza del ricordo delle Regole nonostante la loro abolizione in periodo napoleonico. Tevini, inoltre, elabora una sorta di dizionario per spiegare il significato di alcuni termini contenuti nella Charta (si veda Comitato Charta 2021).
Bibliografia
Fabio Giacomoni (a cura di), "Carte di Regola e Statuti delle comunità rurali trentine", Milano, Jaca Book, 1991.
Comitato Charta della Regola di Cavareno (a cura di), "Charta della Regola della villa di Cavareno del 1632", Trento, Graphic by Massimo Zini, 2021.
Oggetti significativi
La “Ciasa dala Regola” è sicuramente il fulcro attorno al quale ruota la rievocazione storica, sia come continuità durante l’anno, sia come presidio didattico e di ricerca, raccogliendo e unendo tutto il patrimonio andato a stratificarsi negli anni del gruppo “La Stua” e di privati cittadini che hanno donato attrezzi agricoli al Comitato della Charta in vista di un loro riutilizzo in chiave educativa. Inizialmente, la raccolta degli oggetti agricoli era stata incamerata nelle case private di alcuni membri della Charta: nel caso della leader del gruppo, Francesca Malench, si aveva già una consuetudine familiare nel conservare oggetti appartenuti alle generazioni familiari precedenti, quello che lei stessa ha definito come “culto degli antenati”. Gli oggetti venivano movimentati in occasione della rievocazione e riallestiti nei cortili di alcune case private la cui architettura era rimasta fedele al tempo, per poi essere utilizzati nella rievocazione degli “antichi mestieri”. Tuttavia, l’iniziale disponibilità dei proprietari delle case andò scemando, in quanto le case erano passate in mano agli eredi, che non condividevano con la generazione dei genitori e dei nonni lo stesso interesse per la manifestazione e la disponibilità a condividere i propri spazi domestici. Per queste nuove generazioni, infatti, vi era il problema della sicurezza. Da questo momento, scaturì l’idea di allestire gli oggetti in una sede permanente.
Il cugino di Francesca Malench (nel 2010) concesse a titolo gratuito la casa natale della nonna paterna. Il complesso abitativo sorgeva intorno a un centro abitato coevo alla casa ormai disabitato, che un tempo ospitava diverse famiglie. La casa risaliva al 1600 ma venne poi distrutta da un incendio e successivamente ricostruita nel 1906. Le ricerche condotte dal gruppo permisero di allestire la casa seguendo ricostruzioni d’ambiente fornite sia da documenti d’epoca, sia da testimonianze orali delle generazioni più anziane di locali, corroborate dalle memorie personali di alcuni membri della Charta che avevano avuto modo di vivere in case ancora arredate come un tempo, oltre che aver fatto visita più volte a quelle dei nonni. A livello documentale è stato molto importante trovare nell’Archivio di Stato di Trento la stima dei beni, tra il 1700 e il 1780, di tre figlie minorenni che avevano perduto il padre, stilata in vista di una dote matrimoniale. Tali stime comprendevano una descrizione dettagliata degli oggetti della casa e quindi hanno orientato la scelta degli oggetti da parte del Comitato della Charta. Il patrimonio oggettuale di quest’ultimo (non ancora sistematizzato) si aggira a più di cento oggetti. Sono stati rinvenuti anche, grazie alla famiglia Malench, i documenti legati alla gestione della latteria sociale, uno degli elementi produttivi in condivisione propri della Regola, da parte della famiglia Malench. Infatti, il caseificio sociale, istituito nel 1845, era organizzato a turnazione: ciascuna famiglia vendeva i prodotti caseari realizzati con il latte condiviso da tutte le famiglie per ottenere una parte dei proventi. Questo documento attesta quindi sia un aspetto di vita della Regola, sia ancora quest’ultimo all’edificio della “Ciasa”. Il documento è, infatti, esposto nella consolle della camera da letto matrimoniale della casa. Il Comitato ha visitato sia l’Ecomuseo di San Zeno, sia il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina a San Michele all’Adige per poter comprendere meglio come esporre gli oggetti agricoli, sia come rappresentazione scenica, sia come conoscenza delle varie componenti degli attrezzi e le loro tipologie.
Altri elementi precipui del patrimonio materiale della rievocazione sono rappresentati dai costumi utilizzati durante la rievocazione storica, per quanto, come già sottolineato nella sezione “Notizie storico-critiche”, questi ultimi non rappresentano in modo esaustivo la suddivisione in ceti sociali dell’epoca, enfatizzando maggiormente le classi nobiliari. Francesca Malench fa riferimento soprattutto a una pubblicazione del 1820, realizzata da un funzionario dell’Impero Austroungarico, che rappresenta, con disegni ad acquarello, i vestiti “tradizionali” delle varie valli trentine. Altre fonti utilizzate per la realizzazione degli abiti sono una pala del 1700 contenuta all’interno della chiesa di Cavareno, dove è rappresentato il firmatario della Charta (Pietro de Zinis) e i dipinti all’interno della chiesa della Madonna di Senale, di inizio 1600, dove sono raffigurati sia i dignitari che i contadini.
Aspetti immateriali
Stando a quanto riportato dai membri del Comitato della Charta, nel 2011, la Provincia di Trento ha condotto un censimento tra gli abitanti della Val di Non sulla percezione dei locali come minoranza etnico-linguistica: circa il 20% dei partecipanti al censimento si è percepito come ladino. Stando alle politiche provinciali in materia di minoranze, il riconoscimento come minoranza è garantito da un minimo del 15% della popolazione che si percepisce come minoranza. La rievocazione della Charta e la ricerca del gruppo sugli antichi mestieri, già cominciata con “La Stua”, hanno sicuramente offerto elementi utili per il processo di riconoscimento della lingua nonesa, come parte della rivendicazione di costituire una minoranza a sé in Trentino. Un esempio concreto dell’apporto alla cultura materiale nonesa da parte del Comitato è la realizzazione del calendario, distribuito ogni anno in occasione della rievocazione, con all’interno testi (sia poetici che storici) in lingua nonesa e un approfondimento tematico legato alla selezione di fotografie operata per quell’anno. La Provincia finanzia con contributi la realizzazione del calendario, che è forse uno degli elementi costitutivi della rievocazione che riceve più fondi. Le ricerche de “La Stua” furono ulteriormente importanti in quanto approfondirono i termini, in noneso, per indicare gli attrezzi agricoli. Quest’attenzione linguistica viene tutt’ora portata avanti dai membri del Comitato, come Francesca Malench, la quale si è focalizzata sui termini locali per indicare le parti del carro e i finimenti dei cavalli e dei buoi. La stessa teatralizzazione della rievocazione è in lingua nonesa, il che costituisce un elemento problematico per quanto riguarda la trasmissione del sapere collegato alla rievocazione (si veda la sezione sulla trasmissione di questa scheda).
Nonostante queste attività a supporto della lingua nonesa (il Comitato, in particolare, ha collaborato con l’Associazione “Rezia” caratterizzata dalla richiesta di ladinità nonesa per la Val di Non), il riconoscimento non è stato ancora attuato. Una conferenza “Nonesi o ladini”, tenutasi nel 2003 con la presenza del direttore dell’Istitut Cultural Ladin Majon de Fascegn di allora, Fabio Chiocchetti, ha creato, infatti, polemica e resistenza da parte dei ladini già riconosciuti come tali. Il noneso in sé è una lingua a sé stante rispetto al ladino, in quanto presenta delle caratteristiche proprie date dalla vicinanza del confine con la provincia di Bolzano e dalle migrazioni stagionali in altre valli a causa della gestione del bestiame e della coltivazione delle mele.
Altra spinta per il recupero di alcuni elementi del patrimonio immateriale di Cavareno su sollecitazione della rievocazione è rappresentata dalla ricerca del coro parrocchiale, il quale ha recuperato i canti liturgici più antichi utilizzati in paese.
Criticità
Tutti i membri del Comitato della Charta intervistati dalla ricercatrice hanno descritto come a rischio il coinvolgimento giovanile per la realizzazione della rievocazione nel futuro. La rievocazione viene spesso vissuta positivamente dalle giovani generazioni quando sono ancora in età scolare, come un’occasione di divertimento. Una volta cresciuti e, quindi, spostandosi a Trento o in altre città italiane per seguire gli studi universitari, l’attaccamento alla rievocazione scema o, meglio, non si partecipa più attivamente, dando priorità alle proprie esigenze private. Inoltre, come evidenziato dalla figlia di Stefano Battocletti, Flora, il senso globale della rievocazione (e quindi il processo di memorializzazione e ricerca) non viene compreso: la rievocazione è un’esperienza culturale da fruire nell’immediato. Altro rischio è quello legato alla salvaguardia della lingua nonesa: il dialetto, infatti, non viene parlato in casa in presenza dei figli, i quali, quindi, in grande maggioranza non sono in grado di comprenderlo. Si deve inoltre considerare che Cavareno è interessata, più di altri comuni in valle, dai processi migratori: mentre le seconde generazioni di migranti d’origine marocchina si sono sposati con locali e partecipano a pieno titolo alla vita comunitaria, il 25% della popolazione, rappresentata da albanesi e rumeni, non si riconosce nella rievocazione e, in generale, non è stata accolta da un tessuto sociale, come quello trentino, chiuso. Sia per i giovani che per queste generazioni di migranti lo sceneggiato in lingua nonesa non può essere seguito in autonomia ed è per questo che si è introdotto uno speaker che potesse tradurre i passi recitati in italiano.
Un altro fattore di rischio è rappresentato dalla progressiva scomparsa di case “tradizionali” come la “Ciasa” e la conseguente difficoltà di reperire fondi per la sua strutturazione: la casa, infatti, non può essere aperta tutti i giorni in quanto manca il riscaldamento. A Cavareno, infatti, vi è stato uno svuotamento del centro abitato dopo la sperequazione edilizia tra gli anni Sessanta e Settanta che ha portato a un’estensione territoriale, quadruplicando l’estensione di Cavareno. Le case più antiche, in quanto di difficile mantenimento e giudicate dagli abitanti “poco confortevoli”, vengono poi abbandonate una volta che la generazione dei proprietari più anziani si è estinta. È un problema trasversale del Trentino ed è tangibile tuttora addentrandosi tra le vie del paese.
Un ultimo fattore di rischio è rappresentato dalla difficoltà di reperire fondi per la realizzazione e la continuazione della rievocazione. Come si vedrà nella sezione sulle misure di salvaguardia, il Comitato della Charta è stato escluso dai finanziamenti provinciali. Durante le interviste, tuttavia, non è stata data una motivazione di questa esclusione.
Misure di valorizzazione
La valorizzazione della rievocazione è strettamente legata ai programmi didattici nelle scuole da parte dei membri del Comitato della Charta, in particolare Costantino Pellegrini, ex sindaco e segretario del Comitato, oltre che insegnante, e Stefano Battocletti, a sua volta ex insegnante. Da un lato, si sono svolti cicli di conferenze sulla storia dei Comuni della Regola, dall’altro si è utilizzata la “Ciasa” per visite didattiche con le classi. Altre attività di valorizzazione sono da considerarsi le mostre temporanee svolte in concomitanza con la rievocazione storica, nelle quali si recupera la cultura materiale della valle. Un anno, per esempio, sono stati esposti oggetti legati ai culti domestici e pubblici, facendosi prestare oggetti dai valligiani. Nel caso dell’edizione del 2022, quando la ricercatrice era a Cavareno, la mostra verteva sugli orologi trentini, fabbricati principalmente in Val di Non. La collezione in mostra è di un privato milanese ricercato dalla Soprintendenza del Trentino per avere dei consigli su come intervenire nella sistemazione di un orologio del campanile . La mostra è stata finanziata dalla banca CARITRO.
Altra misura di valorizzazione è costituita dalla pubblicazione del calendario noneso. La ricercatrice ha avuto modo di visionare alcuni esempi di calendario noneso. Si segnala, in particolare, il calendario dell’edizione del 2012, realizzato in occasione del ventesimo anniversario della fondazione della rievocazione storica. Le foto delle varie edizioni della rievocazione sono accompagnate da foto contestuali di oggetti specifici presenti nel Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. Il calendario del 2023, distribuito quando era presente la ricercatrice a Cavareno, rappresenta il tema degli orologi realizzati da un antenato di Stefano Battocletti, tema che dà origine anche alla mostra specifica realizzata all’interno della sala civica in piazza Prati.
Il Comitato della Charta ha partecipato all’EXPO di Milano per mettere in scena gli antichi mestieri ed è stato coinvolto in diverse iniziative, quali Pomaria, la Fiera della Mela in valle, e in diverse parti del Veneto, come a Verona per la festa in onore di Giulietta, ad Affi, Pastrengo e a Soave.
Misure di salvaguardia
Il Comune di Cavareno, insieme alla Provincia e alle Casse Rurali sponsorizzano e finanziano la realizzazione del calendario noneso, come già visto in altre sezioni di questa scheda. Inizialmente, la rievocazione riceveva finanziamenti APT. Quest’anno la rievocazione è stata esclusa dai fondi provinciali. A livello di marchi di certificazione, la rievocazione non ha ricevuto riconoscimenti ufficiali, pur essendo il gruppo di coordinamento del Corist (Coordinamento Rievocatori Storici Trentini) e del FECCRIT (Federazione Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino).
Protagonisti
Come si è visto soprattutto nelle sezioni sulle notizie storico-critiche e nel patrimonio materiale e immateriale, la comunità che è dietro l’organizzazione della rievocazione rappresenta la generazione a cavallo tra la fine del secondo conflitto mondiale e la piena introduzione dell’industrializzazione e del boom economico in valle, generazione che, quindi, ha avuto la necessità di documentare e riprendere in mano quello che riteneva stesse scomparendo con gli anni Settanta: dagli antichi mestieri alle case “contadine”, iscrivendosi quindi in parallelo rispetto a tutte le altre iniziative patrimoniali e comunitarie che presero piede in quegli anni in Trentino Alto-Adige (si pensi allo stesso Museo Ladin de Fascia, in cui i curatori museali, attraverso un’etnografia di salvataggio, volevano stimolare una coscientizzazione ladina tra i valligiani). Il Comitato della Charta, quindi, e prima “la Stua” hanno portato avanti quest’operazione identitaria, politica e culturale. Attorno a questo primo nucleo generazionale, si sono poi raccolte le generazioni successive, anche se, come già visto e come si riprenderà in altre sezioni successive a questa scheda, non con la stessa continuità e determinazione, specie per quanto riguarda l’aspetto linguistico, non sufficientemente tramandato all’interno dei nuclei familiari, in un contesto in cui il noneso non riceve adeguate misure di valorizzazione a livello amministrativo. Attraverso conversazioni informali e interviste più strutturate, inoltre, la comunità di Cavareno non sembra aver accolto con lo stesso entusiasmo l’avvento e lo sviluppo della rievocazione storica, sia per quanto riguarda la richiesta di cedere i cortili delle case private per l’esibizione dei figuranti, sia perché la rievocazione storica stessa è stata associata a una determinata amministrazione comunale e, quindi, passabile di suscitare contrasti politici interni, ancor prima che culturali.
Dal sopralluogo etnografico, tuttavia, risulta come la rievocazione storica sia stata accolta dagli esercenti come un momento di attrattiva turistica e, al contempo, di possibile offerta culturale e di svago per chi ha la consuetudine di recarsi a Cavareno in vacanza. I locali, quindi, ma anche le piccole imprese artigianali trovano sicuramente giovamento dalla rievocazione e, al contempo, cercano di contribuirvi. Un cameriere di un bar gelateria “storico” sul retro della piazza principale del paese, per esempio, commentava il fatto che sarebbe passato da casa per vestirsi: tutti i camerieri e baristi del locale erano infatti vestiti in “costume storico” (per quanto maggiormente assimilabile alle sagre folkloriche trentine che a una rievocazione rinascimentale). Lo stesso locale aveva allestito le sale prendendo foto d’epoca di Cavareno e attrezzi agricoli come decorazioni, testimoniando quindi una sensibilità comune ai membri del Comitato della Charta. Presso lo stesso locale, durante il corteo, si sono distinti alcuni baristi per aver salutato un figurante mentre sfilava, rendendo quindi pubblica un’intimità con la rievocazione. Si può quindi pensare che vi siano stati effettivamente esponenti di Cavareno per i quali la rievocazione della Charta rappresenta un momento identitario e conviviale di una certa rilevanza.
Apprendimento e trasmissione
La ricercatrice ha avuto modo di constatare due forme di trasmissione: da un lato, le attività legate al confezionamento dei vestiti, dall’altro quelle che fanno parte della fruizione della “Ciasa”. Per quanto riguarda il primo punto, Francesca Malench ha attivato, insieme alla figlia fashion designer, una serie di stage estivi con ragazze liceali (intorno ai 14 anni) per assistere alla realizzazione dei costumi della sfilata e aiutare nel loro completamento. Questi stage confluiscono nell’ottenimento dei crediti formativi extra-scolastici per le superiori. Per quanto riguarda il secondo punto, le visite guidate alla “Ciasa” diventano un’occasione per le giovani generazioni di apprendere le memorie e le conoscenze tecniche legate alla vita rurale all’interno della Regola. La stessa figlia di Stefano Battocletti, Flora, è stata coinvolta, una volta adolescente e giovane adulta, nello svolgere le visite guidate (ad esempio, era lei che svolgeva le visite guidate alla “Ciasa” nei tre giorni della rievocazione). Questo ha permesso una trasmissione del sapere del padre e dei parenti più anziani, così come di alcuni membri del Comitato, come Francesca Malench. La sua partecipazione alla rievocazione fin da piccola è stata propedeutica per il suo lavoro di guida all’interno della casa. Lo scambio dialogico con i visitatori, provenienti prevalentemente dall’area veneta, le ha permesso inoltre di arricchire il suo repertorio conoscitivo. Tuttavia, il caso di Flora Battocletti è a sé stante. Sono infatti pochi i giovani che si interessano alle ricerche del Comitato della Charta. Quest’ultimo ha provveduto, come modo per avvicinare i giovani e responsabilizzarli nell’eventualità che possano prendere il timone gestionale della rievocazione un giorno, a dare in gestione un bar, di fronte alla sede del Comitato, durante le giornate della rievocazione, la cui cassa sarà poi suddivisa tra i partecipanti.
Metodo Ricerca
La ricercatrice ha avuto modo di contattare i responsabili della Charta attraverso i nominativi datole dalla collega Elisabetta Frasca, la quale aveva già redatto precedentemente la scheda EVE della rievocazione.
Prima di partecipare alla rievocazione, la ricercatrice ha condiviso un documento-canovaccio con la lista di domande utilizzate nelle interviste successive e suddivise per “tipologia” di attori coinvolti (dagli amministratori ai figuranti di personaggi chiave all’interno del corteo). Nel corso della rievocazione, la ricercatrice ha sostenuto conversazioni informali con il segretario della Charta e ha partecipato alla visita guidata alla casa contadina. Tutte le giornate della rievocazione sono state analizzate dalla ricercatrice attraverso un diario di campo, redatto giornalmente. Il fatto che la Charta avesse aiutato la ricercatrice a trovare alloggio nella Casa Vacanze di un gruppo cattolico vicentino ha permesso alla ricercatrice di comprendere come la rievocazione venisse iscritta all’interno delle pratiche turistico-religiose dei villeggianti della Casa. A seguito della rievocazione, la ricercatrice ha avuto modo di condurre sei interviste semi-strutturate, rivolte a elementi chiave della Charta: la famiglia del segretario (la figlia del quale aveva condotto la visita guidata alla casa contadina) della Charta, la presidente, nonché costumista della Charta, un membro della Charta che ha contribuito alla ricostruzione storica e allo scavo dei documenti, e l’ex sindaco di Cavareno che ha implementato la rievocazione. I membri della Charta hanno condiviso con la ricercatrice sia i PDF dei calendari nonesi, sia la trascrizione del testo della Charta. La bozza della scheda è poi stata condivisa con i membri della Charta, sia come forma di restituzione, sia come forma di revisione di eventuali sviste e integrazioni da apporre a quanto scritto dalla ricercatrice.
Localizzazione
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.